Ieri sera ho ascoltato un’intervista in televisione, e la giornalista ha chiesto alla sua ospite quale fosse la sua parola preferita e quale quella insopportabile.
Così, anche io ho risposto nella mia mente. Non ho avuto dubbi: la mia parola preferita è cura, quella che non sopporto è resilienza (non per il suo significato).
Nella parola cura c’è tutto. C’è affetto, amore, rispetto e gentilezza. Quello che immagino appartenere ai legami (familiari, d’amore, terapeutici). C’è la voglia di nutrire il sentimento o la relazione, c’è la gentilezza che dovrebbe esserci sempre in quello che facciamo e siamo. C’è la vera essenza dell’amore, la cui assenza è il frutto della non cura.
Nella parola resilienza c’è il miracolo. C’è la capacità di trasformare i danni in doni, la forza intrinseca di ogni essere umano – anche in chi non sa di averla, o non sa come utilizzarla o canalizzarla – di rialzarsi dopo una caduta. La capacità di non frantumarsi dopo un evento traumatico. Tutto molto bello, in teoria. Ma come si fa, in pratica?
Questa parola così tanto abusata sembra essere diventata la panacea per tutti i mali. Una moda del vivere. Del parlare. Del predicare. Del postare. Un mantra sin troppo superficiale. Con il rischio di svuotarla del suo reale significato dato dal processo psichico che la caratterizza, e di banalizzarla.
Dietro e dentro la parola resilienza c’è un percorso che diventa processo psichico. C’è la fatica del vivere e del trasformare, ma per fare tutto ciò bisogna sapere come si fa; non bisognerebbe essere troppo malconci o affezionati ai propri sintomi (nel mio linguaggio: “il vantaggio secondario dei sintomi”) e bisognerebbe sempre avere il coraggio di ascoltare le proprie cadute e le proprie ferite.
Perché ciò che chiudiamo fuori dalla porta della nostra vita psichica esce dalla porta e entra dalla finestra.
Qual è la vostra parola preferita?
Quando siete intrappolati in situazioni di nostalgica malinconia e passeggiate nei giardini della memoria, quali parole vi accarezzano e quali vi irritano?
Seguimi su Facebook (clicca qui) e su Instagram (clicca qui) e guarda le mie foto.

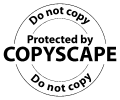


3 Commenti. Nuovo commento
Amore e abbandono: sono le mie due parole. Uno l’aspetto a l’altro temo di non riuscire d’amare una volta e per sempre.
Buongiorno,
sono due parole bellissime e tremendamente concatenate. Amare senza paura di perdere (almeno un po’) l’altro non è amore.
Avere solo paura dell’abbandono, significa avere paura di amare, di abbandonarsi ai pericolosi quanti affascinanti flutti della passione amorosa.
E poi c’è la paura di essere felici che li contiene entrambi.
Nella mia rubrica sull’amore su La Stampa trova più scritti su questo tema; e ansie qui nel sito se cerca tra le varie pagine.
Buona lettura.
Un caro saluto.
Ironia della sorte la mia parola preferita è sempre stata resilienza, molto prima che diventasse comune come il prezzemolo. Per la sua accezione intima nella quale si consuma, l’accettazione silenziosa della consapevolezza che la trincea dell’ultima resistenza coincide con il perimetro del proprio sentire o del proprio corpo, perché un centimetro oltre la pelle e i desideri si può essere nulla e nessuno. Invincibilità piuttosto che sopportazione. Valore piuttosto che riconoscimento.
Un’altra parola altrettanto bella è vicinanza, l’empatia che prescinde da modi e luoghi comuni e si manifesta con delicatezza o irruenza, a seconda della natura, inaspettata e sorprendente, connettendo anime, sancendo attimi di condivisione che legittimano un’intera esistenza.
Mi irritano invece tutte le parole dette a vanvera.