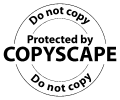In questi giorni assolati e brucianti di agosto si discute sul fine vita. Tema doloroso e forse per alcuni anche scabroso, come se decidere come morire, esattamente come vivere, non fosse un nostro sacrosanto diritto.
Si chiama eutanasia legale.
Ne ho parlato a lungo, in maniera romanzata e drammaticamente vera, perché l’ho vissuto sulla mia pelle e avrei voluto fare, non fare, vivere altro. Avrei voluto accompagnare alla morte mio padre nel profondo rispetto delle sue volontà. Avrei voluto vederlo sulla sua barca ormeggiata ad AciTrezza. Avrei voluto parlare con lui di morte, delle sue paure e delle mie, di come parlarci anche e soprattutto dopo, quali trucchi, strategie, linguaggi muti solo nostri poter adoperare. Io, invece, esattamente come tutti, mi sono accanita per tenerlo in vita consegnandolo a un’atroce sofferenza.
Mio padre ha vissuto fino alla morte ma non ha vissuto la sua morte.
Vi riporto le ultime pagine del mio ultimo libro che parla di lui: “Un clandestino a bordo”, Viola editrice.
Firmai le dimissioni volontarie e andammo a casa.
Le ore che precedono la fine della vita sono drammatiche. Si tratta di un tempo abitato dall’attesa e dall’angoscia, dalla paura e dal silenzio. Quel silenzio religioso spesso profanato con parole vane, nel tentativo di esorcizzare il timore della morte, e da parenti che chiamano, per passare per un’ultima vista a chi sta per andare via.
Tra vicini di casa, parenti mai visti, amici e personale paramedico, mi sentivo invasa e mi riusciva male mettere in pratica la mia attività preferita: scollarmi dalla realtà anche se in compagnia.
La mia psiche, che conosceva bene il dolore, quello altrui e il mio, durante quelle ore si faceva imbrogliare e distrarre dal vociare di sottofondo e da tutto quello che disturbava la mia interiorità.
Mi ero accorta che, forse, avrei dovuto lasciarla fare, perché lei era più saggia di me. Forse, quel caotico andirivieni tra il mio mondo interno, e quello esterno, con le sue futilità, era assolutamente necessario per non soccombere alla sofferenza.
Sapevo che non si poteva intubare con il respiratore artificiale chi non voleva più respirare. Non si poteva idratare chi aveva solo voglia di smettere di soffrire. Non si poteva decidere per chi non aveva avuto la possibilità di dirci come voler morire, per abbracciarci ancora una volta, per proteggerci, per amarci ancora, per farci navigare tra le acque cupe della speranza residua.
Alla fine avevo capito che amare significava lasciar andare.
Non potevo accanirmi tra flebo, tubi, ossigeno e crisi epilettiche. Anche la morte doveva essere dolce. Glielo dovevo. Dovevo lasciarlo andare, anche se questo significava non potergli più tenere la mano, avvertirne il calore, sentirne la protezione.
La morte chiamava e aveva gli occhi del sollievo, il sollievo di un corpo che, nel riposo, ritrova la sua dignità, e di un’anima che finalmente si affranca dalla malattia.
Quel corpo che avevamo maldestramente tenuto in vita, contro tutto e tutti, che avevamo idratato contro la sua volontà, che avevamo intubato cercando vene invisibili e fragili, che avevamo ammanettato alla vita.
Quel corpo che, ormai, conosceva solo il linguaggio dei sintomi. Quel corpo che in silenzio, tra una crisi epilettica e un’altra, ci supplicava di lasciarlo andar via, in un altrove più clemente.
Quando la morte chiama e la vita dei vivi anche, nasce un conflitto.
Io riuscivo a vedere le due forze opposte, le sentivo sulla mia pelle. Erano feroci, spietate, ognuna con la propria verità assoluta. Entrambe camminavano ai lati del letto di mio padre, e parlavano alle nostre orecchie sorde, che non volevano e non potevano sentire.
Quella lotta tra la vita e la morte lo strappava, lo straziava e ci straziava.
Gli regalava una boccata di ossigeno che, subito dopo, si trasformava in una dose massiccia di dolore. Ogni iniezione di vita si trasformava in una iniezione letale postuma.
Eravamo giunti in prossimità del punto dal quale non avremmo più fatto ritorno. Anche quando sei figlia e sei madre, devi avere la forza d’animo e l’onestà di riconoscerlo. Non puoi giocare a fare Dio, non puoi allearti con il delirio di onnipotenza che abita in ognuno di noi, nelle cure sperimentali, nell’accanimento, nella preghiera, nel fato, nella speranza che diventa ossessione.
Avrei dovuto chiedere a mio padre dove avrebbe voluto trascorrere i suoi ultimi giorni, se in casa, in riva al mare, sulla sua barca di fronte ai Faraglioni, in giardino, in cucina con i suoi amati nipoti. Era giusto saperlo. Ed era giusto ascoltarlo. Sarebbe stato onesto e rispettoso.
E invece ci eravamo accanite nel tentativo maldestro e ingiusto di tenerlo in vita, tra flebo e morfina.
Quel punto invisibile era diventato visibile, e si era trasformato irreversibilmente nel punto di non ritorno. Amare significava non tenere più in vita, perché la vita era altro e altrove, anche senza di me, anche senza di noi, le persone che mio padre aveva sempre amato e protetto.
Stavo aspettando che quel soffio di vita che lo ancorava ancora alla vita, e che gli regalava dosi massicce di dolore, andasse via. Per sempre.
Ogni giorno cercavo un posto segreto, che mi potesse accarezzare e proteggere. Avevo sempre creduto che ognuno di noi avesse un posto speciale in cui rifugiarsi, un posto segreto. Anche dentro un tramonto o dentro un ricordo o un odore d’infanzia.
In quei mesi la realtà mi faceva paura, era dolente e deludente, così utilizzavo la fantasia come luogo in cui estraniarmi. La scrittura, come sempre, era il mio rifugio. Volevo stare da sola, e non volevo condividere con nessuno il mio dolore. La fantasia era diventata il mio esilio emotivo, magico e riparatore. Sin da bambina, insieme a mio padre, giocavamo con la fantasia, passavamo dal concreto al simbolico, e dal simbolico al concreto. Disegnavamo, lavoravamo con il legno, davamo una forma alle nuvole, giocavamo con le parole, con i gesti, con i segni che diventavano disegni.
Avevo imparato a scegliere un rifugio in cui andare, fisicamente o con il cuore, per ritrovarmi o perdermi del tutto.
Tra i miei posti preferiti c’erano la casa di mia nonna, il profumo della sua merenda preparata con amore, la soffitta di casa e la casa sull’albero, le confessioni sotto le coperte prima di andare a letto, i giochi con la fantasia e la scrittura. Tra questi luoghi, ve ne era uno più bello e più importante, incredibilmente riparatore: il cuore di mio padre. Lo stesso cuore che adesso aveva deciso di duellare con la morte per non lasciarlo andare via.
Da adulta, il rapporto con la realtà non era cambiato molto; le strategie per renderla indolore o per silenziarla non dovevano essere poi così diverse. Dovevo soltanto trovarle, ancora una volta.
Ero adulta, ma volevo essere ancora figlia. Il mio altrove era difficile da trovare, indossava abiti diversi, amava il trasformismo in funzione delle esperienze vissute o subite. Mi trasportava da ieri a domani senza chiedermi il permesso.
In quei giorni, avevo smarrito il mio posto segreto. Nessun foglio word e nessun libro, nessun abbraccio e nessuna parola
Mi ero smarrita del tutto.
Qualche ora prima.
Ero in studio, lavorare mi aiutava a non sentire e a non pensare troppo, o troppo a lungo. Il lavoro era il mio oppio, la mia droga legalizzata, ma non leggera.
Utilizzavo il mio eccesso di senso del dovere per stordirmi rispetto al mio buco nel cuore.
Ero in macchina e, come spesso accade quando sono ferma a un semaforo, stavo scrivendo. Avevo bisogno di seguire il flusso delle mie paure e delle mie fragilità e di trasferirle dentro il mio cellulare.
Stavo andando a casa dei miei, ma ero certa che sarebbe stata la sua ultima sera con noi e per noi.
Avevo capito che l’istante prima di morire era carico di tutta la vita. Era un momento di una forza strabiliante. L’ultimo respiro era come il primo. Intenso e spirituale, ma non volevamo accettarlo.
Maria, l’infermiera che si occupava di mio padre, aveva appena terminato di lavarlo, di pettinarlo e di profumarlo. Nonostante fosse chiaramente in bilico tra la vita e la morte, lei proseguiva parlandogli con dolcezza.
“Pulito, rinfrescato e con il pigiama nuovo. Così devi stare”.
Si ostinava a dargli del tu, mio padre non rispondeva, e per lei era il modo più intimo e affettuoso di occuparsi di lui.
Sapeva bene che, se fosse stato sveglio e lucido, avrebbe avuto grande difficoltà a farsi accudire da una donna. Non avrebbe mai accettato un declino così repentino.
“Adesso sei in ordine. Così mi piaci!” gli sussurrava nelle orecchie come se lui potesse sentirla, tra una manovra decisa e un’altra.
Maria diceva che bisognava occuparsi del corpo anche quando il corpo non aveva più voglia di rimanere lì.
Mia madre, mia sorella e io eravamo atterrite, inebetite. Per noi era molto più importante sopravvivere alle crisi epilettiche e sincerarci che non si fosse fatto troppo male. Il corpo era diventato qualcosa da accudire in termini esclusivamente medici, le cure della pelle e dell’anima ci sembravano fuori posto. Maria, invece, donna concreta, si occupava di mio padre come se fosse “vivo” e come se stesse per partecipare a una serata di gala. Nei nostri cuori sapevamo che sarebbero state le sue ultime ore, ma non avevamo nessuno strumento che ci consentisse di venire fuori dalle nostre paure per connetterci con i suoi desideri. Le crisi epilettiche diventavano sempre più incalzanti, e il tempo tra l’una e l’altra si restringeva sempre di più.
Non c’era modo di rallentare il tempo, nemmeno le nostre preghiere funzionavano.
“Eccola che arriva” gridava mia mamma, nella speranza che qualcuno di noi le potesse dare una mano. Ci guardava con sguardo supplichevole, aveva gli occhi sottili come una fessura, gonfi di pianto e disperazione. La voce era roca e tuttavia stridula. Nessuno sembrava sapere cosa fare se non aspettare che quella ennesima crisi, che sembrava davvero infinita e più cattiva del solito, passasse.
Avevo imparato a sentire l’odore della crisi epilettica. Avevo imparato talmente tante cose dai miei cani, da imitarne il comportamento. In un momento di atroce dolore attuavo degli automatismi senza nemmeno rendermene conto. Mi sentivo esattamente come loro: odoravo l’aria. Diventava intensa e acre, piena di niente e di tutto. Drammaticamente intensa. Le crisi epilettiche erano tutte uguali, eppure tutte diverse.
Arrivavano da lontano e ci portavano lontano.
Ci trasferivano con brutalità e malvagità in un altro posto, del tutto ignoto. In un luogo buio, senza speranza alcuna, in cui si poteva soltanto stringere gli occhi per evitare di vedere il dopo, e sperare che questo passaggio obbligato passasse presto.
Questo luogo informe e paludoso ci aspettava con cronometrica precisone. Le crisi epilettiche si succedevano con cadenza costante, ogni ora, ogni mezz’ora, sino a quindici minuti l’una dall’altra.
Un tempo troppo ridotto per dare la possibilità a mio padre di recuperare ossigeno e riposo, e a noi speranza.
Arrivavano come un’onda anomala che spazzava via tutto: corpo e psiche. Come l’alta marea rientra lentamente, lasciando detriti e conchiglie, la crisi lasciava in noi disperazione, sconforto e confusione circa il sentire e il volere. E allora riappariva il solito strazio: desiderare la vita o sperare nella morte.
Mio padre veniva attraversato da una scossa elettrica, un braccio gli si muoveva di scatto e gli si adagiava dietro la testa, per tornare subito dopo al suo posto. Simulava un movimento traendoci in inganno. Le lacrime solcavano il suo volto, nonostante gli occhi rimanessero ben serrati. Smetteva di respirare, sembrava contorcersi dal dolore e, più aumentava il dolore, più noi non sapevamo cosa fare per lenire o velocizzare la sua agonia.
“Guarda si muove” articolava mia mamma tra le lacrime, parlando a voce bassa e strascicando le parole come se volesse masticarle. Mia madre era sempre stata una donna razionale, lucida, fortemente ancorata alla realtà, qualunque essa fosse. Immagino che, in quel momento, si sentisse estranea a se stessa, confusa, incoerente. Ma quando il cuore sanguina, anche la mente diventa anarchica.
A ogni movimento di mio padre, dettato dalla impetuosità della crisi epilettica, mia madre vedeva un segno di ripresa.
“Mamma, i movimenti sono frutto della crisi, non è papà che si muove, è la crisi che attiva un riflesso incontrollato” ribadivamo a turno Manuela e io.
Anche Maria, con il suo linguaggio popolare e incisivo, la rimproverava e la rasserenava.
Aveva un modo di parlare tutto suo, una sorta di siciliano italianizzato per l’occasione, infarcito di metafore e di archetipi.
Nella nostra isola, il rapporto con la morte indossa un abito ambivalente: se da un lato le anime dei defunti vengono mandate via con preghiere che ricordano dei riti, come se i morti potessero contaminare i vivi, dall’altro vengono invocati per chiedere protezione e aiuto.
Maria, con i suoi racconti, sembrava incarnare la nostra ambivalenza culturale e del cuore.
In Sicilia non sappiamo cosa sia la festa di Halloween, noi abbiamo la festa dei morti. Era novembre e c’era ancora nell’aria la nostra festa, che sembrava essersi trasferita nel soggiorno di casa, ove mio padre stava adagiato nel letto che lì avevamo collocato.
La nostra tradizione popolare, rappresentata egregiamente da Maria, vuole che, nella notte tra l’1 e il 2 novembre – data che rappresenta la linea di confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti – accada una magia.
Le anime dei defunti possono entrare in contatto con i loro cari, portando con sé dolci e regali da far recapitare ai bambini, a testimonianza della loro indiscussa presenza nelle loro vite e del loro vegliare sull’intera famiglia.
Quando, inoltre, un membro della famiglia sta per cessare la sua vita terrena, si dice che la notte che precede il trapasso un familiare morto venga in sogno e annunci che lo verrà a prendere da lì a breve.
Maria cucinava, accudiva, puliva e raccontava. In lei era custodita tutta la nostra sicilianità, tra sacro e profano.
Maria, però, preferiva il fare al parlare. “Ci penso io”: questa era la sua frase parafulmini. Quando l’angoscia diventava insopportabile, lei agiva. Faceva qualcosa, qualunque cosa.
Andava in cucina, rassettava, preparava un tè, spostava le medicine da un posto a un altro pur di fare e le rimetteva nello stesso posto subito dopo. Il suo fare era per noi un dare amore e cura. Ogni suo gesto ci sembrava una carezza, qualunque cosa facesse.
La sua attività preferita era lavare mio padre. Era per lei un rituale di cura e di speranza.
Con la sua andatura da militare, audace e ritmata – Maria non indietreggiava davanti a niente e nessuno – si recava in bagno, scaldava l’acqua, si assicurava che la temperatura fosse esattamente come lei voleva che fosse, tirava su la manica del suo maglione e immergeva il gomito dentro quel piccolo catino adibito, usandolo come termometro.
Quando l’acqua era a temperatura, iniziava il suo rituale. Stendeva un asciugamano su mio padre, un panno di lino bianco delle mie nonne che odorava di pulito e di casa, lo sbatteva per bene per togliere le pieghe, e cominciava. Lo adagiava con precisione maniacale per evitare di bagnarlo dove non era previsto che lo bagnasse, e iniziava a lavarlo.
Prendeva la spugna, la immergeva nel catino, la ruotava su se stessa e la strizzava subito dopo, per trasferirla sul collo, sulle braccia ormai livide per i troppi buchi provocati dagli aghi che avevano trapassato il corpo di mio padre.
Maria non si lasciava impressionare da niente: né dagli ematomi, lividi e gonfi, né da un’anima che sperava di lasciare lì a breve il suo corpo-armatura.
Lei era fiera, orgogliosa del suo essere infermiera, fattiva e generosa.
Era diventata una di noi, una presenza centrale in casa, rassicurante.
L’ultima crisi epilettica fu la più devastante, atroce e senza via di ritorno.
Il tempo si era fermato, il suo cuore anche. Mio padre aveva smesso di respirare e di soffrire.
Un viavai di gente profanava la nostra casa e il nostro dolore. I vicini di casa – con cui aveva condiviso i favori, il sale, lo zucchero, il tagliaerba e le punte del trapano – venivano a trovarlo per un ultimo saluto.
Mia madre piangeva senza sosta, incredula. Lo chiamava per nome nel tentativo vano e disperato di riportarlo in vita. Non voleva rimanere da sola, e non voleva lasciarlo da solo. Non lo aveva mai fatto durante tutti gli anni trascorsi insieme. Non voleva rinunciare al compagno di una vita. Mia sorella non versò una lacrima, e non ne versò neanche nei giorni, nei mesi e negli anni a seguire. Si alleò con la parte pragmatica di Maria e insieme sistemarono casa. Occuparsi delle cose concrete era una manovra del suo inconscio per non sentire troppo dolore. Nel giro di quindici minuti, la stanza di mio padre era totalmente rassettata.
I farmaci che aveva utilizzato per cercare di sopravvivere il più a lungo possibile erano stati riposti negli appositi armadietti, lontani dalla nostra vista ma non dai nostri pensieri. I presidi ospedalieri che lo avevano accompagnato durante le sue ultime settimane, erano stati depositati in garage; il pavimento insaponato e lavato a dovere. I signori che avrebbero organizzato il funerale si erano già materializzati come eleganti e accorati avvoltoi. Non c’era nulla che fosse fuori posto, se non mio padre nella sua bara color acero. Il suo legno preferito.
Mio nipote Ruggero era sempre stato un bambino di poche parole. Talvolta mi ricordava in maniera preoccupante sua madre. Temevo per la sua incolumità psichica, per il controllo eccessivo delle sue emozioni; pur essendo un bambino non perdeva mai il controllo, non gridava, non faceva capricci e non puntava i piedi.
Ingoiava silenziosamente tutti gli eventi della vita, anche quelli più sgradevoli per un bambino, e con un sorriso autentico, non di circostanza come quello degli adulti, andava avanti.
Da appena un’ora suo nonno, il suo migliore amico, il suo compagno di giochi e di merende, non c’era più, e questa notizia drammatica lo avrebbe dovuto consegnare allo sconforto. Ruggero, invece, coerentemente con le sue emozioni, dignitoso nella sua sofferenza, si era trasferito in cucina, e in assoluto silenziom si era impossessato della sua penna antidolorifica, di un foglio, e aveva iniziato a disegnare e a scrivere.
Tratto dopo tratto, lacrima dopo lacrima, aveva disegnato una barca da corsa. Era l’offshore di suo nonno, e un po’ anche il suo. Luogo di ricordi e di navigazioni. L’ultima barca, Ultima, con la quale il nonno aveva gareggiato e con cui la domenica lo portava al mare, raccontandogli storie di navigazione e di campioni. Prese il foglio e lo piegò su se stesso più volte, con una manualità che ricordava esattamente quella di mio padre.
Quel foglio piatto si era trasformato in una barca in tre dimensioni. Aveva smesso di piangere, aveva asciugato i suoi occhi come per darsi un contegno e presentarsi a suo nonno ordinato e dignitoso. Si era recato nella stanza in cui era posta la bara ancora aperta, aveva preso la barca che aveva disegnato e creato per lui, e l’aveva adagiata dolcemente sulle sue mani, insieme a una lettera che gli aveva scritto. La lettera conteneva delle lettere tondeggianti e asimmetriche che seguivano
pedissequamente il rigo o la linea, e non l’onda anomala della sua sofferenza. Ruggero sembrava mettere in pratica gli insegnamenti di suo nonno. Gli aveva scritto poche frasi, ma profonde e grate. Lo ringraziava per tutto quello che aveva fatto per lui e per gli insegnamenti ricevuti.
Nonostante Ruggero fosse un bambino, non gli faceva impressione toccare un morto, né parlare con il corpo di quello che, fino a qualche ora prima, era stato suo nonno. Sapeva bene che sarebbe rimasto tale anche dopo, e per sempre.
Ruggero, in realtà, era un adulto. Era nato grande.
Era il 23 novembre, Santa Lucrezia, l’onomastico di mia figlia, ed ero certa che mio padre sarebbe andato via proprio quel giorno.
Quel segno, quella magia, quel filo che ci avrebbe tenuti insieme per sempre lo stavamo tessendo insieme. Lui andava via e si trasformava in un angelo custode personale per la parte più importante di me: mia figlia, la sua tanto amata nipote.
Ore 21:04 del 19 novembre del 2001: mia figlia nasceva.
Ore 21:04 del 23 novembre, il suo onomastico: mio padre moriva. I miei più grandi amori, le mie radici e le mie ali, legati per sempre.
Ecco, era il segno che mio padre mi aveva regalato.