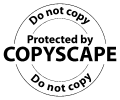Attenzione: questo articolo può causare indignazione e marcata irritazione. Leggere le istruzioni prima di addentrarsi tra le righe.
- Non giudicare subito.
- Arrivare sino all’ultima parola per porsi, porre delle domande e darsi delle risposte, preferibilmente oneste.
- È un tema divisivo che invita al politicamente corretto, ma non è questo il caso.
Ho scritto con la penna inzuppata nell’inchiostro del mio essere clinico, mamma, figlia, donna, scrittrice, aggiustatrice di cuori. Non obbligatoriamente in quest’ordine.
Buona lettura e grazie per la pazienza.
C’è chi un figlio non lo vuole e chi lo vuole a tutti i costi, in ogni modo, in ogni dove, anche in uteri altrui.
Quando si parla di genitorialità, ma soprattutto di maternità, si squarciano gli animi e si squaderna quella indispensabile dose di buon senso residuo, quel lumicino che dovrebbe rimanere sempre acceso e dovrebbe orientare le scelte o le non scelte genitoriali.
Chi mette al mondo un figlio, talvolta e per sfortuna, corre il rischio di derubricare la scelta genitoriale dalla dimensione di sacralità e dall’obbligatorio impegno futuro a una scelta fatta a cuor leggero. Un figlio solo per il fatto di averlo messo al mondo dovrebbe inchiodare alla responsabilità della sua crescita, a prescindere dalle motivazioni occulte o generose che hanno generato la scelta.
Un figlio come trofeo narcisistico, contro ogni limite d’età, in menopausa, senza un partner, in assenza di adeguate condizioni cliniche o psichiche, fomenta il mercato degli embrioni e la tratta delle schiave e degli uteri in affitto.
All’altro estremo abbiamo donne che un figlio non lo vogliono perché questo mostriciattolo si prenderebbe tutto: tempo, spazio, libertà e luce.
Ho riflettuto a lungo e credo che questi due estremi siano meno estremi di quanto sembrino. Il denominatore comune rimane l’egoismo e anche l’egocentrismo, nutriti e fomentati da una buona dose di paura: della solitudine, della vecchiaia e della morte, della cura e del prendersi cura, dell’abbandono e delle sue mille gradazioni emotive, e in fondo dell’amore.
Nel dibattito di queste settimane nato su La Stampa, sempre su maternità e dintorni, ho letto tanti contributi e tante versioni soggettive del tema trattato, ma una frase, solo una, scritta da Assia Neumann Dayan, mi è rimasta incisa nel cuore e mi ha dato un pugno in pancia, ricordandomi quello che in fondo sapevo già e cercavo di dimenticare: “Avere un figlio ha molto più a che fare con la paura della morte che con la vita, o con la pensione, e ogni riflessione mi sembra legittima e fragile.
La maternità tra l’illogico e l’indispensabile
Mi sono chiesta perché il tema maternità sia così cocente e anche così dannatamente irrazionale. Mi sono chiesta perché debba seguire logiche illogiche e soggettive, viscerali. Perché abbiamo bisogno della legge per avere degli argini e dei confini al delirio di onnipotenza dilagante da maternità a ogni costo.
E poi mi sono chiesta perché alcune donne indossano la corazza della non maternità: la scelta (apparentemente) consapevole di non volere figli pur potendoli avere.
Scelte assolutamente non sindacabili – non è questo il punto – ma da dover analizzare oltre la superficie dell’apparenza.
Scattano le solite frasi fatte, tremendamente abusate: “un figlio obbliga alle rinunce, alla fatica, al dire addio all’aperitivo con le amiche, sino ad arrivare alla possibile perdita del posto di lavoro”. E per finire: “essere donna non significa per forza avere un figlio”; come se una donna senza figli fosse meno donna e una donna con più figli fosse invece più donna, e come se la completezza e la magia dell’essere donna fosse strettamente correlata al suo utero fecondato.
Sono trascorsi secoli dalle etichette diagnostiche come isteros, da hystéra, che significa ventre, utero, ninfomane, un termine che evoca la genitalità femminile, deriva dal greco “nympé” che significa clitoride, vulva (ninfa) e manìa, enfatizzando la correlazione tra organi sessuali e possibili patologie psico-sessuologiche, sempre al femminile, frigiditas – frigidus”, che rimanda a un concetto di siberia sessuale, usato impropriamente sempre e soltanto al femminile.
Siamo ben distanti dalle immagini stereotipate dell’angelo del focolare che veglia la pentola mentre fa sobbollire il sugo e dalla donna in carriera, algida e con i pantaloni, allergica ai legami affettivi e longevi. Come se un’identità dovesse obbligatoriamente escluderne un’altra.
Oggi, dopo fatiche inenarrabili, almeno in Italia, la donna è una e centomila. Può portare il suo tubino nero con un elegante tacco dodici e cambiare un pannolino, portare i pantaloni e dedicarsi al sugo mentre lavora su skype. Fare tutto e anche niente senza dover giustificare il suo desiderio. Abbiamo padri in astensione lavorativa per la paternità e madri che scelgono di non allattare, padri che cambiano un pannolino e che scaldano un biberon, e ruoli morbidi e intercambiabili che abitano in coppie equilibrate e risolte.
Tornando a “un figlio per forza, un figlio mai”, credo che le motivazioni, soprattutto inconsce, che muovono le fila di queste due scelte così estreme siano altre, non visibili da un primo sguardo o rintracciabili in uno o più scritti.
Dimmi che figlio sei stato e ti dirò che genitore sarai, se lo sarai o non lo vorrai
Ognuno di noi è stato figlio e il cammino verso la dimensione adulta – amorosa e genitoriale – non è sempre un percorso pianeggiante. C’è chi è ancora figlio perché, in fondo, non è mai stato partorito. Il figlio cronico, il figlio delle viscere. Il prediletto. Colui che vive in un bagno d’amore prolungato ed eccessivo che talvolta diventa risorsa altre volte sabbie mobili, trappola.
Ci sono i figli in panne, che fanno fatica a stare al mondo. Poi ci sono le pecore nere , le mie preferite: i figli ribelli. Coloro che duellano contro le convenzioni e il si deve, che sfidano le regole paterne o materne, pur consapevoli di sacrificare sull’altare sacrificale l’approvazione e talvolta l’amore genitoriale.
Ci sono i figli devoti: i soldati obbedienti. Coloro che non si ribellano. Che crescono buono e zitti, che studiano anche quello che non gli piace, che praticano uno sport che non amano o suonano uno strumento che detestano, e che finanche sposano un partner accontentandosi.
Ci sono i solitari e i soli: gli orfani di genitori vivi oppure i figli del divorzio (non tutti i divorzi sono equilibrati e sereni).
Quei figli partoriti e metaforicamente abbandonati a loro stessi. Figli che imparano a cavarsela nella vita ma hanno paura dell’amore e dell’abbandono. Figli che sono costretti a diventare i genitori dei loro genitori, per incuria o infantilismo.
Ci sono ancora i figli traumatizzati, gli ignorati. I maltrattati, allora e sempre.
Ci sono, poi, gli affamati d’amore. I figli che si muovono tra senso di colpa e senso del dovere, coloro che hanno una sola missione: barattare l’amore per la bravura e l’obbedienza, per dimostrare che lui, lei, è un buon figlio anche da adulto, perché, in fondo, ha quella parte bambina che ancora duole.
Ci sono poi i figli-adulti-bambini: coloro che cercano di riparare le ferite del non amore ricevuto. I non amati, portatori di quella ferita sanguinolenta e dolente.
Ci sono anche i figli trofeo. I bambini costretti a specchiarsi nello sguardo compiaciuto del genitore che rivive in lui e che lo rende una compensazione delle sue mancanze. Ci sono poi i mutilati. Quei figli che ricordano coloro che hanno dolore all’arto fantasma, soffrono per quello che non hanno più o forse non hanno mai avuto, che mai penserebbero di procreare per non correre il rischio di diventare come la loro madre o il loro padre.
Schierarsi e ridurre a una sola risposta un tema così complesso è miope e mutilante
A volte, nella solita diatriba tra mente e cuore, la ragione stenta a seguire il passo zoppo del cuore; così prende il sopravvento per tutela, per proteggere dall’andatura claudicante, sino a condurre a un cammino pianeggiante, apparentemente immune dalle fatiche del vivere.
Per diventare genitori si deve passare dal tunnel buio dell’essere stati figli. Non ci sono altre strade. Il trigenerazionale torna a bussare alla porta del cuore, ci orienta o ci fa schiantare su scelte estreme, tormentate e tormentanti.
Il genogramma familiare, per esempio, è uno strumento che si utilizza in terapia ed è una sorta di albero genealogico che rappresenta graficamente – e quindi visivamente – le relazioni di parentela tra i componenti di una famiglia, sino ad abbracciare ben tre generazioni. Viene redatto dal racconto delle relazioni (o trappole relazionali) che il paziente fa in seduta. Grazie a questo strumento si evidenziano le strutture triangolari della famiglia, le disfunzionalitá e il modo inconscio di riproporle nelle generazioni successive (quindi poveri figli!), le sofferenze causate da cosa o da chi, e davvero tantissimo altro.
Come sempre, soprattutto in amore, parte sempre tutto da laggiù: dalle terre dell’infanzia, da come siamo stati amati o non amati, da quanto abbiamo sofferto e se siamo stati riparati o ci siamo riparati da soli.
In fondo è facile confondere i desideri con le paure.
I primi, quando non trovano uno spazio di elaborazione adeguata, sono bravi a travestirsi da paure. In studio ne vedo davvero tante.