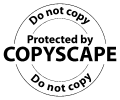La figura della madre continua a rimanere, tristemente, alla ribalta. Impazza in televisione, colonizza i media, i giornali: oscilla tra sciagure e tragedie correlate al ruolo di genitrice.
Dall’assassinio di Cogne ad altri casi di cronaca, i media ci inondano di immagini di madri assassine, disturbate e disturbanti.
Bambini accoltellati nel sonno mentre, innocentemente, sono tra le braccia di Morfeo. Altri strangolati, altri ancora travolti da raffiche di pallottole.
Famiglie distrutte e sterminate dal dolore e dalla perdita di controllo.
Gli avvocati, nelle loro arringhe difensive scrivono: “Gli assassini sono depressi, incapaci di intendere e di volere”.
La depressione viene citata e adoperata come strumento difensivo per cause scomode, portatrici di dolore e dalla dubbia interpretazione.
La famigerata e abusata depressione diventa una sorta di lasciapassare per giustificare i crimini più efferati. Il male oscuro di cui sembra soffrire un italiano su cinque non sempre è direttamente correlata a così tante atrocità. Un altro aspetto da non sottovalutare è il passato di chi arriva a uccidere; solitamente prima del gesto nefasto aveva manifestato altri sintomi , forse non proprio così eclatanti, ma sicuramente la concretizzazione di un disagio.
La malattia psichica non può essere utilizzata sempre come alibi per tutti i delitti, ma andrebbe maneggiata con cura e con rispetto, evitando pericolose e discriminanti associazioni tra depressione e omicidi.
Secondo un doloroso resoconto il 2014, i bambini sono le vere vittime di delitti compiuti dai genitori.
Anche in questo caso esiste una divergenza di genere nei toni accusatori o deresponsabilizzanti che vengono adoperati in tribunale.
Quando è il padre a compiere le stragi si dice che trattasi di un uomo disturbato, trafitto dal dolore dell’abbandono o uno stalker (diagnosi ormai abusata), mentre quando è la madre a uccidere i figli, viene adoperata la diagnosi di depressione.
La depressione. Qualche nota clinica
L’episodio depressivo costituisce una delle esperienze più destabilizzanti per chi si trova a doverlo vivere o meglio subire.
Il paziente racconta – tardivamente rispetto al suo esordio – che si sente senza speranze, senza energie né risorse, completamente impotente di fronte alle esperienze della vita e al mondo che lo circonda.
Riferisce che gli vengono a mancare le energie per poter fare qualsiasi attività, fisica e mentale, tutto diventa senza sapore né odore: perde il gusto della vita.
Quando si parla di depressione, tutto sembra avere smarrito il suo colore e sapore, tutto appare un vero e proprio fallimento.
Il paziente riferisce di vivere un susseguirsi di perdite – reali o simboliche – di cui spesso ci si sente responsabile; è abitato da una sensazione di impotenza.
Talvolta, attribuisce agli altri e agli eventi della vita la colpa del suo dolore dell’anima, del disagio e della sfortuna che dimora nelle sue giornate.
L’isolamento è spesso cercato, voluto e al tempo stesso subito, ma nonostante ciò appare inevitabile e il paziente non intravede nessun’altra strada da poter percorrere. Chi soffre di depressione non è in grado di svolgere le cose più semplici: dallo svegliarsi al mattino, lavarsi e occuparsi di sé stesso e degli altri, alle sequenze più complesse e impegnative che obbligano a un impegno mentale ed emozionale, come far fare i compiti ai propri figli o svolgere le proprie mansioni lavorative.
Il vissuto è tra i più nefasti: sensi di colpa, inadeguatezza, il vedere tutto nero e un peso sul cuore che non lascia via di scampo a nessun tipo pensiero.
Chi soffre di depressione viene rapito da una vera e propria incapacità di vivere e da un “mal di vivere”, amplificate dal pensiero ricorrente di morte.
È un quadro grave, visibile, quantizzabile e soprattutto non mistificabile. Non avviene all’improvviso.
Guglielmo, figlio di una madre assassina
Guglielmo mi contatta in piena estate, quando lo studio sarebbe dovuto essere chiuso. Era agosto, c’erano trentotto gradi centigradi, e il caldo afoso siciliano aveva intorpidito tutto, rendendo difficile anche respirare. Mi sembrava una richiesta assurda, sin troppo urgente per essere veritiera.
(Solitamente quando un paziente chiama di domenica, ad agosto, per Natale, non desidera risolvere davvero, ma spera di ricevere una sorta di cerotto del momento; oppure, inconsciamente, spera che lo studio sia chiuso, come spesso accade, per dire a sé stesso che lui, in fondo, ci aveva tentato.)
Soltanto dopo comprendo che quella sua richiesta di aiuto conteneva in realtà paura e coraggio, bisogno e disperazione. Guglielmo ha ventitré anni e si è da poco innamorato. Mi consulta in preda al terrore di avere i geni di sua madre.
Ha paura che da innamorato possa uccidere.
In una prima fase non comprendo, perché lui omette particolari salienti della sua disastrosa infanzia. Mi racconta dopo due incontri di essere stato adottato dalla zia, la sorella del padre, e di avere vissuto lì sino alla sua maggiore età. La storia di Guglielmo è una storia controversa, molto complicata, intrisa di sofferenza e di strappi del cuore.
La madre di Guglielmo, Anna, ha sempre sofferto di un disturbo bipolare di personalità, mai diagnosticato. Alternata alti e bassi, esaltazione del tono dell’umore a euforia estrema.
Anna, quando era in fase maniacale, era una super mamma. Giocava, cantava, ballava. Preparava delle torte, tante, anzi tantissime torte, spendeva tutti soldi che aveva da parte, e anche quelli che non aveva. Ma dopo crollava.
Il buio si impossessa di lei e di Guglielmo, si rinchiudeva in camera e non parlava più, non cucinava più, non faceva più la mamma. Non si lavava per settimane, diventava collerica e scontrosa se qualcuno, spesso Guglielmo, tentava di farla ragionare o di accudirla. Lo cacciava, lo maltrattava, lo aggrediva.
Un giorno la madre, in preda a quello che i medici hanno chiamato raptus omicida, ha accoltellato il padre pugnalandolo per ben venti volte nel petto.
Guglielmo aveva appena compiuto tredici anni. Il suo mondo si è frantumato in mille pezzi. Era diventato irreversibilmente orfano: il padre morto e la madre in carcere. Probabilmente per sempre.
Cresce con una zia, la sorella del padre, ma si rifiuta di andare in terapia. Nella sua mente e nel suo cuore si insidia un’equazione indissolubile: chi ama uccide.
Sono trascorsi anni, agosto si è fatto settembre, e gennaio giugno.
Guglielmo sta rivisitando il dolore, stiamo curando la sua paura d’amare e di fare l’amore. Il deficit erettivo psicogeno nel quale era intrappolato sta lentamente lasciando il posto a una sessualità scaldata dall’intimità e dal coraggio: di essere felice, di amare ancora e di poter essere ancora amato.
Omicidi d’amore o per amore
La depressione, solitamente, in casi estremi, porta al suicidio di chi ne soffre, non conduce di certo all’omicidio della persona cara, trasformando il protagonista di tanto dolore, soprattutto allo sguardo dei media e delle persone care, in un vero killer. Il malato vede il mondo tutto nero, senza risorse, carico di minacce. In questi casi decide di uccidere i propri figli e togliersi poi la vita a sua volta.
Questo modus operandi rappresenta una strategia malsana e patologica per proteggere i loro amori – i bambini per l’appunto – e sé stessi dalla vita e dal dolore.
La diagnosi postuma di depressione, a omicidio avvenuto, non sempre è fattibile.
Chi soffre di depressione grave non può celare il suo disagio, il suo dolore e il suo efferato malessere, non può fingere di stare bene sino al giorno prima dell’omicidio ed esplodere all’improvviso e senza preavviso.
La “depressione maggiore” è una depressione importante e non può essere improvvisata e utilizzata in maniera fantasiosa da avvocati e mass-media.
Resnick, nel 1970, è stato il primo a stabilire la differenza tra neonaticidio – termine adoperato per le uccisioni di bambini appena nati, esattamente entro le 24 ore -, infanticidio – termine relativo ai bambini minori di due anni – e figlicidio – l’uccisione di un figlio che ha superato i due anni di vita.
Diventare mamme, un difficile percorso
Diventare mamma non è un processo semplice e soprattutto non è soltanto un evento biologico, ma psicologico e psico-relazionale, irto di ansie, sensi di colpa, paure e difficoltà. Tante mamme, durante il difficilissimo dopo parto, hanno gridato aiuto e sono state confuse per donne stanche, stressate, nient’affatto ammalate.
Non tutte vengono travolte da quel buio assoluto, da quella necessità omicida, dal baratro dell’esistenza.
Da mamma e da clinico penso che fare, anzi “essere mamma”, sia un percorso complesso, sfaccettato, complesso in termini di dinamiche consce e inconsce; spesso i sensi di colpa e di inadeguatezza si intersecano agli eventi della vita facendoli precipitare in un pozzo senza fondo.
Una madre che uccide il proprio figlio é una donna che uccide una parte di sé stessa senza in realtà morire, è una donna che, nel caso raro decidesse di non uccidersi dopo, sopravvive al figlio e “rimane in vita da morta”.
Sopravvivere alla morte di un figlio è la cosa peggiore che possa mai accadere, rappresenta la morte psichica peggiore che ci sia: la vita, in seguito, con il suo susseguirsi di albe e di tramonti, diventa una punizione atroce e insopportabile.
La psiche, poi, con i suoi meccanismi di difesa, anestetizza, rimuove, fa dimenticare, organizza strategiche amnesie e in qualche modo fa sopravvivere queste mamme omicide.
Il possibile profilo di questi omicidi
Frustrazione, rabbia, cattiva gestione della frustrazione portano a dolorosi “passaggi all’atto” di tipo omicida, che in psicoanalisi si chiamano “acting out”.
La facile diagnosi di depressione associata a questi efferati omicidi nuoce gravemente ai pazienti depressi, perché temono di poter diventare anche loro dei killer e pensano di poter essere giudicati e temuti come tali dal mondo circostante. Questa malattia va rispettata e conosciuta a fondo. Le diagnosi non dovrebbero essere strumentalizzate per fini legali, se non vi è una chiara e lampante correlazione tra sindrome depressiva e omicidio.
Valeria Randone